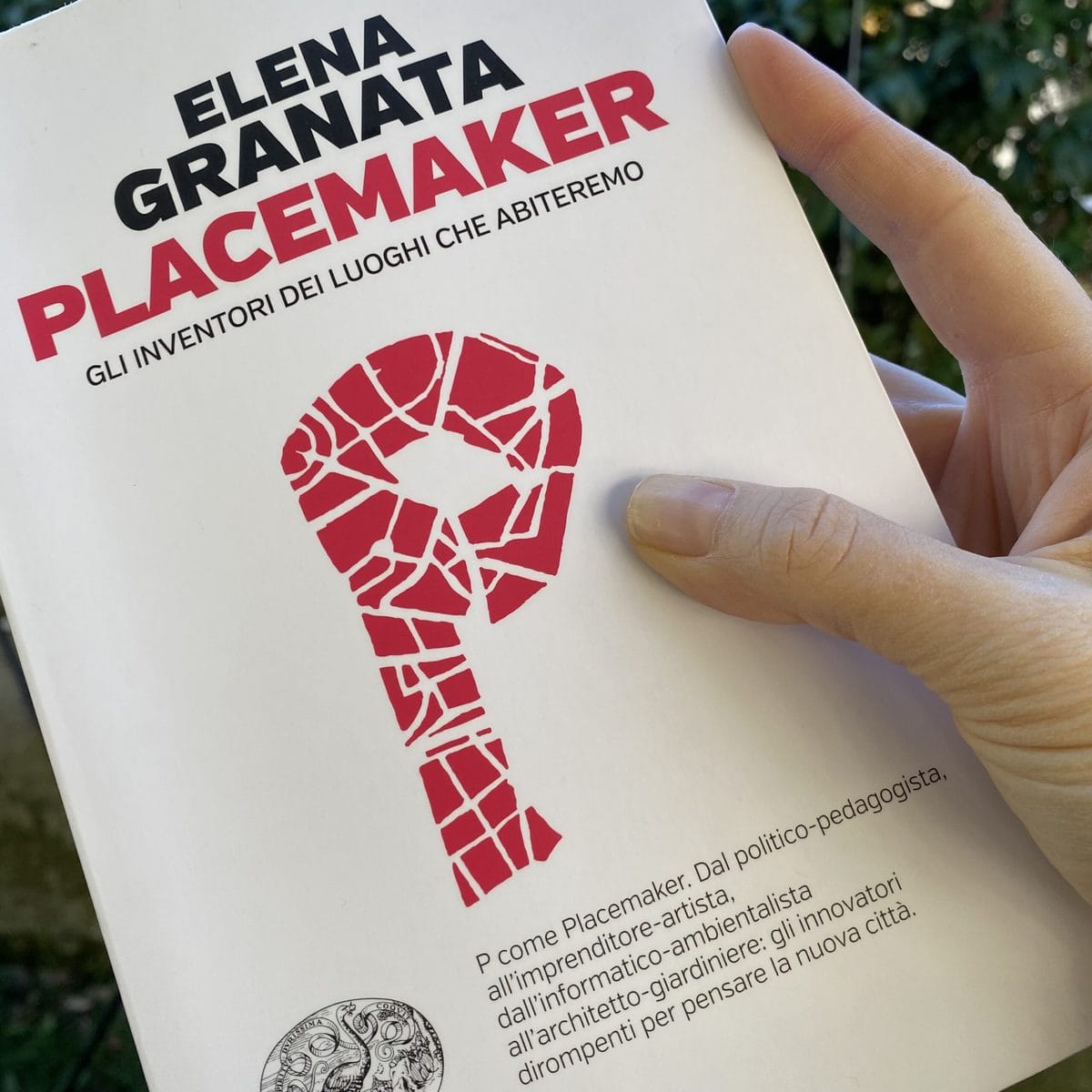di Francesca Ameglio
Chi sono gli inventori dei luoghi che abiteremo? Ce lo dice Elena Granata nel suo nuovo libro Placemaker.
Non è un architetto, non è un politico, né un imprenditore. Non è uno scienziato e neanche un artista. In modo provocatorio, Elena Granata nel suo libro Placemaker arriva a prefigurare l’estinzione delle archistar come quella dei dinosauri e fa emergere una nuova generazione di designers fuori dal comune, fratelli minori, indisciplinati, addirittura inconsapevoli. Apprendisti stregoni, santi ed eroi, a volte inventori di luoghi per caso. Nuovi Ulissi in cerca di esperienze di senso che ritornano per prendersi cura dei luoghi.
A prima vista questa affermazione sembra voler escludere intere categorie che da sempre si occupano di città, ma in realtà le include tutte.
Fa saltare i vecchi ambiti disciplinari perché i problemi reali delle città non rispettano i confini.
Per comprendere la complessità dei sistemi urbani non servono specialisti, ma intelligenza collettiva e orizzontale, meno profonda ma più estesa.
In questo senso il Placemaker è una figura nuova e insieme antichissima che sa divertirsi e quindi, letteralmente sa volgere lo sguardo altrove (divertere). Una intelligenza che sa stare tra competenze e saperi diversi (transdisciplinare), che connette, ibrida, mescola, fino a trasformarsi in qualcosa che non è facile da incasellare.
Nel suo libro Elena ci racconta tante storie. Quando ci siamo sentite, abbiamo inevitabilmente incrociato le molteplici e incredibili storie, professionali e personali, dei Placemaker descritte nel libro, con quelle, forse meno emblematiche ma altrettanto variegate, dei ragazzi e delle ragazze del Master U-Rise. E si assomigliano tantissimo. I loro percorsi formativi non sono mai lineari, coltivano passioni e sono curiosi verso quello che non conoscono, disposti a seguire anche il proprio istinto, a porsi domande e a non prendere per buoni tutti i modelli ereditati.
Tra le tante storie che si incontrano in questo libro, molte sono quelle al femminile, quasi a ricostruire una genealogia dell’architettura e dell’urbanistica e fornire un inedito punto di vista delle città. Sono donne come Jane Jacob, giornalista e scrittrice statunitense dalla penna affilatissima, autodidatta, sposata a un architetto di cui condivideva lo spirito e l’approccio, madre di tre figli. Il suo Vita e morte delle grandi città pubblicato nel 1961 è un importantissimo contributo di analisi e critica sugli ecosistemi urbani e sociali americani oggi più che mai attuale. Come Elizabeth Diller che, insieme al marito Ricardo Scofidio, nel 2004, realizzano il progetto per la High Line di New York, restituendo alla città un luogo straordinario, senza fare architettura, togliendo piuttosto che aggiungendo, innamorandosi di tutta quella biodiversità fatta di piante selvatiche e di boscaglie, di insetti e di fiori arrivati da chissà dove, sulla ferrovia abbandonata. Il loro non-progetto ha fatto scuola e oggi non è più un’eccezione.
Le donne dimostrano di saper essere all’altezza: Ada Colau a Barcellona, London Breed a San Francisco, Claudia López Hernández a Bogotá, sanno amministrare strategicamente le loro città, gestiscono le emergenze e hanno visioni di lungo periodo, liberandosi un po’ di quell’immaginario socialmente rassicurante della cura. Hanno in comune la grande sensibilità per la vita quotidiana, per la sicurezza e i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli e svantaggiati.
Ma c’è ancora tanta strada da fare. Le nostre città incorporano le norme di una società che è stata fino adesso miope e non ha mai preso in seria considerazione comportamenti, abitudini e differenze di chi le abita. Lo standard, la misura a cui ci siamo sempre appoggiati, come un parametro universale, non rende ragione a nessuno. La città alfabetica calata dall’alto lascia il posto alla città del tempo. Alla vigilia della pandemia la sindaca di Parigi Anne Hidalgo lancia l’idea della ville du quart’heure: servizi e funzioni prossimi, organizzati sulla base del tempo che le persone impiegano per raggiungerli a piedi o in bicicletta. Un tentativo per riconciliare lo spazio urbano con i corpi e la vita reale delle persone.
È necessario quindi cambiare il modo di guardare i luoghi e di farlo da tante prospettive diverse, dal basso, passandoci attraverso, ogni giorno. Un placemaker non può astrattamente immaginare una città.
I placemakers del futuro, Elena li incontra tutti i giorni al Politecnico di Milano e alla Scuola di Economia Civile dove insegna. La loro curiosità si mescola con la paura e la difficoltà di gestire l’imprevedibilità dei tempi che stiamo vivendo, ma allo stesso tempo vedono nella crisi in corso anche una grande opportunità di cambiamento.
Questo libro è bello perché di buon senso. Il buon senso con cui dovremmo ricominciare a pensare la città del futuro, ripartendo dai vuoti, senza però riempirli. Facendo posto creando spazio, come diceva Giovanni Michelucci. È un libro capace di alimentare la curiosità verso quello che non conosciamo, perché quello che non sappiamo può rivelarsi la nostra più grande risorsa per immaginare il futuro.
Vi consiglio questa lettura perché alla fine vi sentirete profondamente ispirati e potrete far volare la vostra creatività. E non preoccupatevi se vi chiameranno farfalline!
![]()